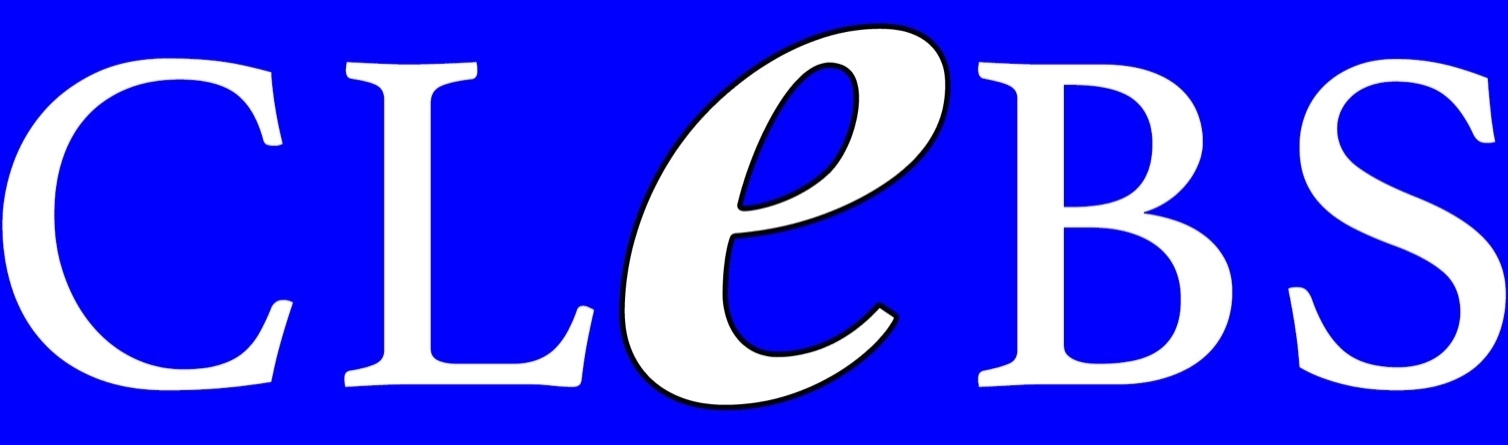Caro Cantini, le parole non sono neutre: in politica lasciano segni
06-01-2026 09:41 - Opinioni
di Emilio Chiorazzo
Le parole non sono mai semplici suoni affidati all’aria o segni lasciati distrattamente su una tastiera. In politica, soprattutto, le parole costruiscono immaginari, aprono o chiudono spazi di convivenza, tracciano confini morali. Per questo non sono – e non possono essere – neutre.
Il commento pubblicato sui social da Isacco Cantini, dirigente di Fratelli d’Italia a Empoli, a margine del presidio per la Pace organizzato sabato pomeriggio dal Comitato per la Pace contro l’intervento americano in Venezuela, va letto esattamente in questa prospettiva. L’uso del verbo “sterminare”, rivolto agli avversari politici, non è una semplice caduta di stile né una provocazione mal calibrata: è una parola che porta con sé un peso storico, simbolico e umano enorme. È una parola che richiama la cancellazione dell’altro, la negazione radicale dell’umanità altrui. E non è neppure la sola. Altre volte in passato Cantini ha utilizzato un linguaggio inappropriato e figlio di un passato politico che non andrebbe… rispolverato neppure col vocabolario.
Che a scriverla sia un dirigente politico rende la vicenda ancora più grave. Che apre una riflessione su come e a chi vengono affidati alcuni compiti dai partiti. Chi ricopre incarichi di responsabilità non parla mai solo a titolo personale, neppure sui social. Ogni parola pronunciata o digitata contribuisce a definire il clima pubblico, a legittimare o delegittimare comportamenti, a spostare l’asticella di ciò che viene ritenuto accettabile. In un tempo già segnato da tensioni, guerre e polarizzazioni estreme, la leggerezza non è un’attenuante, ma un’aggravante.
Le scuse arrivate successivamente, doverose, non possono essere considerate automaticamente risolutive. Non perché il diritto all’errore e al ripensamento debba essere negato, ma perché la responsabilità politica impone uno standard più alto. Le parole non possono essere ritirate come si ritira un post, né neutralizzate con una dichiarazione tardiva. Restano, circolano, producono effetti.
In queste ore, come documentato anche dagli interventi pubblicati su Clebs, la vicenda ha suscitato prese di posizione nette da parte di forze politiche, rappresentanti istituzionali e realtà civiche. Segno che il problema non riguarda una sensibilità individuale, ma una questione collettiva: il confine tra confronto politico e linguaggio della violenza. Un confine che, se oltrepassato, non può essere archiviato come un incidente di percorso.
C’è infine un elemento che merita di essere sottratto a ogni strumentalizzazione: la disabilità di Cantini. Essa non attenua né aggrava le sue parole, perché la responsabilità politica non conosce sconti identitari. Al contrario, proprio perché la storia ci insegna dove portano certi linguaggi, chiunque – a maggior ragione chi vive sulla propria pelle forme di vulnerabilità – dovrebbe avvertire il dovere di vigilare sulle parole, prima ancora che sugli avversari.
La pace, i diritti, la convivenza democratica non sono temi di parte. Sono il terreno minimo comune su cui una comunità si riconosce. E se le parole cominciano a evocare lo sterminio, anche solo come insulto, significa che qualcosa di profondo si sta incrinando.
Per questo non basta chiedere scusa. Serve fermarsi, riflettere, assumersi fino in fondo il peso di ciò che si dice. Perché in politica, più che altrove, le parole non passano mai senza lasciare traccia.
Le parole non sono mai semplici suoni affidati all’aria o segni lasciati distrattamente su una tastiera. In politica, soprattutto, le parole costruiscono immaginari, aprono o chiudono spazi di convivenza, tracciano confini morali. Per questo non sono – e non possono essere – neutre.
Il commento pubblicato sui social da Isacco Cantini, dirigente di Fratelli d’Italia a Empoli, a margine del presidio per la Pace organizzato sabato pomeriggio dal Comitato per la Pace contro l’intervento americano in Venezuela, va letto esattamente in questa prospettiva. L’uso del verbo “sterminare”, rivolto agli avversari politici, non è una semplice caduta di stile né una provocazione mal calibrata: è una parola che porta con sé un peso storico, simbolico e umano enorme. È una parola che richiama la cancellazione dell’altro, la negazione radicale dell’umanità altrui. E non è neppure la sola. Altre volte in passato Cantini ha utilizzato un linguaggio inappropriato e figlio di un passato politico che non andrebbe… rispolverato neppure col vocabolario.
Che a scriverla sia un dirigente politico rende la vicenda ancora più grave. Che apre una riflessione su come e a chi vengono affidati alcuni compiti dai partiti. Chi ricopre incarichi di responsabilità non parla mai solo a titolo personale, neppure sui social. Ogni parola pronunciata o digitata contribuisce a definire il clima pubblico, a legittimare o delegittimare comportamenti, a spostare l’asticella di ciò che viene ritenuto accettabile. In un tempo già segnato da tensioni, guerre e polarizzazioni estreme, la leggerezza non è un’attenuante, ma un’aggravante.
Le scuse arrivate successivamente, doverose, non possono essere considerate automaticamente risolutive. Non perché il diritto all’errore e al ripensamento debba essere negato, ma perché la responsabilità politica impone uno standard più alto. Le parole non possono essere ritirate come si ritira un post, né neutralizzate con una dichiarazione tardiva. Restano, circolano, producono effetti.
In queste ore, come documentato anche dagli interventi pubblicati su Clebs, la vicenda ha suscitato prese di posizione nette da parte di forze politiche, rappresentanti istituzionali e realtà civiche. Segno che il problema non riguarda una sensibilità individuale, ma una questione collettiva: il confine tra confronto politico e linguaggio della violenza. Un confine che, se oltrepassato, non può essere archiviato come un incidente di percorso.
C’è infine un elemento che merita di essere sottratto a ogni strumentalizzazione: la disabilità di Cantini. Essa non attenua né aggrava le sue parole, perché la responsabilità politica non conosce sconti identitari. Al contrario, proprio perché la storia ci insegna dove portano certi linguaggi, chiunque – a maggior ragione chi vive sulla propria pelle forme di vulnerabilità – dovrebbe avvertire il dovere di vigilare sulle parole, prima ancora che sugli avversari.
La pace, i diritti, la convivenza democratica non sono temi di parte. Sono il terreno minimo comune su cui una comunità si riconosce. E se le parole cominciano a evocare lo sterminio, anche solo come insulto, significa che qualcosa di profondo si sta incrinando.
Per questo non basta chiedere scusa. Serve fermarsi, riflettere, assumersi fino in fondo il peso di ciò che si dice. Perché in politica, più che altrove, le parole non passano mai senza lasciare traccia.