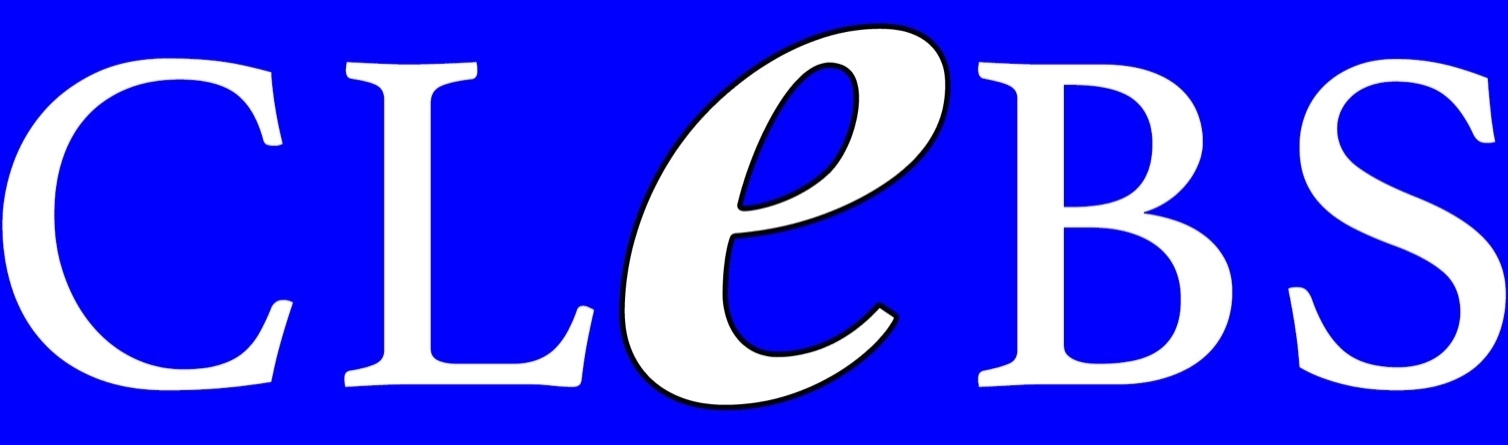"La storia non è mai solo passato ma un ponte tra ieri e oggi", la sfida di /Conté.sto/
08-09-2025 11:55 - Le interviste di Clebs.it
di Emilio Chiorazzo
"La storia è la scienza degli uomini nel tempo", così diceva Marc Bloch, uno dei più grandi storici del Novecento. E così sottolinea l'assessore alla cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi nel raccontare la prima edizione del festival di storia contemporanea che prederà il via il 12 settembre. "E' su questa visione che vive /Contè.sto/. Non un evento statico, ma un'occasione per guardare la storia contemporanea sotto una luce nuova: una storia che non è solo da raccontare, ma da comprendere nel nostro presente, per capire meglio le sfide e i dilemmi del futuro" sottolinea Bensi.
Il festival, fortemente voluto dal Comune di Empoli, si propone di restituire al pubblico una storia viva e pulsante, che non sia solo il racconto di eventi lontani, ma un'esperienza che interagisce con il nostro quotidiano. Il tutto attraverso lezioni pubbliche, dibattiti, e un'intensa riflessione sul nostro tempo, con la partecipazione di alcuni dei più importanti storici italiani. E con il coinvolgimento di 14 classi delle scuole superiori della nostra città che hanno dato la loro adesione per assistere a quelle che saranno vere e proprie lezioni di storia.
Assessore Bensi, partiamo dall'inizio: come nasce l'idea di un festival di storia contemporanea?
È un'idea che nasce, in realtà, da una riflessione condivisa con il sindaco. Un po' più di un anno fa, avevamo deciso di esplorare nuove strade per portare cultura in città. Volevamo un'iniziativa che non fosse solo di divulgazione, ma che alzasse anche il livello del dibattito cittadino. Abbiamo così pensato che fosse urgente, in questi tempi così turbolenti, mettere al centro della nostra agenda culturale la storia, ma una storia che parli del nostro presente e delle sfide del nostro futuro. Come diceva Marc Bloch, la storia non è mai solo passato, ma un continuo dialogo con il presente. Se non comprendiamo le dinamiche storiche, non possiamo comprendere a fondo la realtà che viviamo oggi. È proprio questa la spinta che ci ha portato a creare /contè.sto/. Sempre per citare lo storico tedesco, la storia deve essere una finestra sul mondo attuale, non una mera cronaca del passato. Nel nostro festival, storici e storiche di generazioni diverse affronteranno temi cruciali come guerra, democrazia, colonialismo, e razzismo, per farli dialogare con la realtà odierna. I protagonisti, con le loro lezioni pubbliche, restituiranno la tridimensionalità di eventi che hanno plasmato la contemporaneità, ma che continuano a influenzarci. Il nostro obiettivo è proprio quello di dare concretezza a una storia inclusiva, che ci riguarda tutti."
E in effetti oggi, a distanza di un anno, questa urgenza sembra diventata ancora più evidente…
Sì, esattamente. Un anno fa era una percezione forte, ma adesso è sotto gli occhi di tutti. Viviamo in un tempo in cui la storia è costantemente invocata, ma spesso in modo strumentale, semplificato. Era necessario creare uno spazio dove la storia fosse trattata per quello che è: una disciplina rigorosa, complessa, capace di aiutarci a leggere il presente.
Per farlo vi siete affidati a una direzione scientifica…
Sì, volevamo costruire qualcosa di serio, non improvvisato. Per questo ci siamo rivolti a Carlo Greppi, storico e scrittore che da tempo lavora su questi temi anche con un forte impegno civile. È fuori dal mondo accademico nel senso più stretto, ma profondamente connesso alla ricerca e alla divulgazione di qualità. L'ho conosciuto anche grazie alle sue partecipazioni al Premio Pozzale, e mi ha colpito molto il suo libro “Storie che non fanno la Storia”. Un lavoro che illumina vite e vicende spesso marginali, ma che sono parte integrante dei processi storici. Con lui abbiamo costruito una squadra di storici e storiche straordinaria, con competenze che coprono l'intero arco della contemporaneità, dall'Ottocento a oggi.
Il titolo del festival, “/Conté.sto/”, incuriosisce. Perché questa scelta?
Il titolo è un manifesto. /Contè.sto]/ è scritto proprio come un lemma, come si trova nei vocabolari. L'idea è che la storia non sia solo una successione di date o eventi, ma uno strumento per dare senso al presente. Il contesto, appunto, è ciò che permette di comprendere davvero quello che ci accade intorno. È uno sforzo, certo, perché richiede complessità, profondità. Ma oggi più che mai serve resistere alla semplificazione, al rischio delle narrazioni polarizzate.
Un riferimento, anche implicito, al modo in cui oggi si parla di memoria?
Sì, la memoria è un campo fondamentale, ma è anche divisiva: è sempre una memoria mia o tua, di parte. La storia invece può e deve essere un terreno condiviso, faticoso forse, ma necessario. Pensiamo alle polemiche sui “giorni della memoria”, alle date, alle commemorazioni: semplificare spesso significa schierarsi, dividere. La storia, al contrario, ha la forza di costruire una visione più ampia, più inclusiva.
Nel programma c'è anche una parte legata al territorio. Come si inserisce questa dimensione locale nel festival?
Era fondamentale. Abbiamo un patrimonio importante di studiosi e studiose che lavorano sul nostro passato locale, e volevamo coinvolgerli fin da subito. L'esperienza del convegno sui Fatti del ‘21 è stata un esempio: lì abbiamo cercato di affrontare la complessità, senza cedere alla divisione tra posizioni ideologiche. Contesto è anche figlio di quell'approccio. Le associazioni del territorio hanno risposto con entusiasmo e saranno parte attiva del festival.
Qual è l'ambizione più grande di contesto?
Credo che sia quella di creare un nuovo spazio civico. Un luogo – anche simbolico – dove le cittadine e i cittadini possano ascoltare, confrontarsi, imparare. Dove la storia non sia solo una materia scolastica, ma una chiave per leggere il mondo. Se /Conté.sto/ riuscirà a fare anche solo un po' questo, avremo centrato l'obiettivo.
Il festival, fortemente voluto dal Comune di Empoli, si propone di restituire al pubblico una storia viva e pulsante, che non sia solo il racconto di eventi lontani, ma un'esperienza che interagisce con il nostro quotidiano. Il tutto attraverso lezioni pubbliche, dibattiti, e un'intensa riflessione sul nostro tempo, con la partecipazione di alcuni dei più importanti storici italiani. E con il coinvolgimento di 14 classi delle scuole superiori della nostra città che hanno dato la loro adesione per assistere a quelle che saranno vere e proprie lezioni di storia.
Assessore Bensi, partiamo dall'inizio: come nasce l'idea di un festival di storia contemporanea?
È un'idea che nasce, in realtà, da una riflessione condivisa con il sindaco. Un po' più di un anno fa, avevamo deciso di esplorare nuove strade per portare cultura in città. Volevamo un'iniziativa che non fosse solo di divulgazione, ma che alzasse anche il livello del dibattito cittadino. Abbiamo così pensato che fosse urgente, in questi tempi così turbolenti, mettere al centro della nostra agenda culturale la storia, ma una storia che parli del nostro presente e delle sfide del nostro futuro. Come diceva Marc Bloch, la storia non è mai solo passato, ma un continuo dialogo con il presente. Se non comprendiamo le dinamiche storiche, non possiamo comprendere a fondo la realtà che viviamo oggi. È proprio questa la spinta che ci ha portato a creare /contè.sto/. Sempre per citare lo storico tedesco, la storia deve essere una finestra sul mondo attuale, non una mera cronaca del passato. Nel nostro festival, storici e storiche di generazioni diverse affronteranno temi cruciali come guerra, democrazia, colonialismo, e razzismo, per farli dialogare con la realtà odierna. I protagonisti, con le loro lezioni pubbliche, restituiranno la tridimensionalità di eventi che hanno plasmato la contemporaneità, ma che continuano a influenzarci. Il nostro obiettivo è proprio quello di dare concretezza a una storia inclusiva, che ci riguarda tutti."
E in effetti oggi, a distanza di un anno, questa urgenza sembra diventata ancora più evidente…
Sì, esattamente. Un anno fa era una percezione forte, ma adesso è sotto gli occhi di tutti. Viviamo in un tempo in cui la storia è costantemente invocata, ma spesso in modo strumentale, semplificato. Era necessario creare uno spazio dove la storia fosse trattata per quello che è: una disciplina rigorosa, complessa, capace di aiutarci a leggere il presente.
Per farlo vi siete affidati a una direzione scientifica…
Sì, volevamo costruire qualcosa di serio, non improvvisato. Per questo ci siamo rivolti a Carlo Greppi, storico e scrittore che da tempo lavora su questi temi anche con un forte impegno civile. È fuori dal mondo accademico nel senso più stretto, ma profondamente connesso alla ricerca e alla divulgazione di qualità. L'ho conosciuto anche grazie alle sue partecipazioni al Premio Pozzale, e mi ha colpito molto il suo libro “Storie che non fanno la Storia”. Un lavoro che illumina vite e vicende spesso marginali, ma che sono parte integrante dei processi storici. Con lui abbiamo costruito una squadra di storici e storiche straordinaria, con competenze che coprono l'intero arco della contemporaneità, dall'Ottocento a oggi.
Il titolo del festival, “/Conté.sto/”, incuriosisce. Perché questa scelta?
Il titolo è un manifesto. /Contè.sto]/ è scritto proprio come un lemma, come si trova nei vocabolari. L'idea è che la storia non sia solo una successione di date o eventi, ma uno strumento per dare senso al presente. Il contesto, appunto, è ciò che permette di comprendere davvero quello che ci accade intorno. È uno sforzo, certo, perché richiede complessità, profondità. Ma oggi più che mai serve resistere alla semplificazione, al rischio delle narrazioni polarizzate.
Un riferimento, anche implicito, al modo in cui oggi si parla di memoria?
Sì, la memoria è un campo fondamentale, ma è anche divisiva: è sempre una memoria mia o tua, di parte. La storia invece può e deve essere un terreno condiviso, faticoso forse, ma necessario. Pensiamo alle polemiche sui “giorni della memoria”, alle date, alle commemorazioni: semplificare spesso significa schierarsi, dividere. La storia, al contrario, ha la forza di costruire una visione più ampia, più inclusiva.
Nel programma c'è anche una parte legata al territorio. Come si inserisce questa dimensione locale nel festival?
Era fondamentale. Abbiamo un patrimonio importante di studiosi e studiose che lavorano sul nostro passato locale, e volevamo coinvolgerli fin da subito. L'esperienza del convegno sui Fatti del ‘21 è stata un esempio: lì abbiamo cercato di affrontare la complessità, senza cedere alla divisione tra posizioni ideologiche. Contesto è anche figlio di quell'approccio. Le associazioni del territorio hanno risposto con entusiasmo e saranno parte attiva del festival.
Qual è l'ambizione più grande di contesto?
Credo che sia quella di creare un nuovo spazio civico. Un luogo – anche simbolico – dove le cittadine e i cittadini possano ascoltare, confrontarsi, imparare. Dove la storia non sia solo una materia scolastica, ma una chiave per leggere il mondo. Se /Conté.sto/ riuscirà a fare anche solo un po' questo, avremo centrato l'obiettivo.